8 Storie salvate all’Oblio delle Bombe Atomiche – Parte Prima
- lo scrigno del mistero
- 12 set 2019
- Tempo di lettura: 11 min
di ROBERTO COCCHIS
Un evento storico di portata epocale è sempre paragonabile a un enorme calderone in cui finiscono a bollire e a fondersi tra loro, in modo da non essere quasi più distinguibili, innumerevoli esistenze spesso diversissime, inevitabilmente destinate a non lasciare traccia se non in modo fuggevole e fortunoso. Per secoli, la storiografia ufficiale ha ignorato quel poco che era rimasto di queste importantissime fonti, ma nel XX secolo le cose hanno cominciato a cambiare.
Il contributo delle studiose femministe e, soprattutto, l’impronta lasciata dal metodo di Michel Foucault hanno aperto la cultura storica alla voce della gente comune, quella che fino a qualche secolo prima non aveva neanche la possibilità di lasciare alcuna testimonianza al futuro perché condannata all’analfabetismo. Da allora, la percezione della Storia è cambiata, almeno per quella minoranza di persone che ha la volontà di andarsela a studiare, anche soltanto per curiosità, senza accontentarsi del “sentito dire” strumentale cui viene incessantemente sottoposta dai mass media.
La Storia del XX secolo è stata intensa e quasi frenetica nel suo succedersi di avvenimenti epocali, ma almeno uno di essi, pur preparandosi in un lungo periodo negli anni precedenti ed estendendo le sue conseguenze fino ai giorni nostri, ha segnato una fondamentale discontinuità rispetto al passato, perché ha cambiato radicalmente il modo di concepire la guerra e di conseguenza la diplomazia e le politiche internazionali. In pratica, il mondo è cambiato enormemente tra il 6 e il 9 agosto 1945, quando gli USA fecero esplodere i primi (e, grazie a Dio, finora unici) ordigni atomici in un bombardamento strategico, sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, stroncando ogni velleità di resistenza da parte del popolo nipponico.
Lo schema della distruzione della bomba sulla città di Hiroshima. La sfera rossa indica il punto di deflagrazione:

L’esplosione dei due ordigni, oltre alle distruzioni materiali e alle altre conseguenze, uccise complessivamente tra le 100.000 e le 200.000 persone, quasi tutte civili. Già il fatto che le cifre siano così incerte la dice lunga sul valore della singola vita umana di fronte a un tale avvenimento. Stiamo parlando di 100.000 persone di cui non si sa che fine abbiano fatto, se siano morte o meno, se siano morte lì e mai ritrovate o altrove e mai ritrovate ugualmente; 100.000 persone, come a dire la somma degli abitanti di Rieti, Gorizia e Sondrio, tre dei nostri capoluoghi di provincia, per la Storia rappresentano una inevitabile approssimazione, visto che i dati disponibili sono tutt’altro che precisi.
La prossima volta che passeremo per Rieti, Gorizia, Sondrio o qualunque altro capoluogo di dimensioni comparabili alle loro, soffermiamoci a guardare tutte le persone per la strada e pensiamo che un evento come quello delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, in un attimo, potrebbe non solo cancellarle completamente dalla faccia della Terra, ma anche cancellare totalmente ogni loro ricordo, sicché uno storico del futuro, anche in possesso della migliore documentazione possibile sul nostro periodo, potrebbe arrivare a pensare che non siano mai esistite.
Per questo, dobbiamo considerare tanto più preziose le non molte esistenze che si sono salvate da questo immenso dimenticatoio. Perché in mezzo a queste persone che potrebbero svanire nel Nulla come se non fossero mai esistite ci siamo anche noi.
L’impegno e la volontà di alcuni superstiti ha permesso ad alcune di queste esistenze di sopravvivere all’oblio, nonostante tutto. Ciò che è rimasto non è moltissimo, ma è molto significativo. Di seguito, racconteremo tre tra le più significative di queste storie. Altre seguiranno in un successivo articolo.
Il medico di Hiroshima
Michihiko Hachiya, nato nel 1903, era un medico, originario di Okayama, che si era trasferito a Hiroshima per lavoro ed aveva fatto carriera fino a diventare il direttore dell’Hiroshima Communications Hospital, sito in uno degli edifici che, pur danneggiati, non furono abbattuti dall’onda d’urto dell’esplosione, a poco meno di 2 chilometri da questa. Abitava in una piccola casa molto vicina all’ospedale e, al momento dell’esplosione, stava riposando perché era appena rincasato da un turno di notte.

La sua casa fu distrutta dall’onda d’urto, ma lui e la moglie si salvarono. Decisero dunque di trasferirsi nell’edificio dell’ospedale. Qui, naturalmente, entro breve tempo, cominciarono ad affluire decine e poi centinaia di sopravvissuti feriti, ustionati e poi vittime della malattia da radiazioni. Il dottor Hachiya, pur nella scarsità di mezzi a disposizione, riuscì a organizzare un efficiente servizio di pronto soccorso e medicina d’urgenza cooptando tutti i medici e gli infermieri disponibili che, per diversi giorni, insieme alle loro famiglie, vissero nell’ospedale, accanto ai pazienti. Ogni sera, il dottor Hachiya redigeva un diario in cui registrava gli arrivi dei pazienti, i loro miglioramenti o peggioramenti, le loro dimissioni o la loro morte.
Dopo diversi giorni, ripristinate finalmente le comunicazioni, le autorità giapponesi riuscirono a far giungere i soccorsi ai sopravvissuti delle due bombe e il dottor Hachiya poté tornare gradualmente alla normale attività. Le sue annotazioni di diario coprono il periodo dell’emergenza, che va dal 6 agosto al 30 settembre 1945. Dopo la guerra, le organizzò in uno scritto che pubblicò su una rivista medica giapponese, “Teishin Igaku”. Nel 1950, questo scritto finì casualmente davanti a un medico americano appartenente alla task force che studiava gli effetti delle bombe, Warren Wells.
Wells convinse Hachiya a ricavarne un libro, che uscì nel 1955 con il titolo “Diario di Hiroshima” ed è disponibile anche in Italiano. Il libro di Hachiya è un documento storico molto importante ma anche un eccezionale documento scientifico, perché mostra in presa diretta lo sgomento dei medici davanti all’insorgenza di malattie fino a quel momento inspiegabili, in persone apparentemente rimaste illese. Il dottor Hachiya è morto di cancro nel 1980, ma non si sa se la sua malattia possa essere correlata alla sua esposizione agli effetti della bomba atomica.
Il sopravvissuto a entrambe le bombe
Questa è una delle storie più difficili da trattare, perché esistono molte fonti in contraddizione tra loro, in tutte le lingue. Una versione parla di otto persone che, complessivamente, sarebbero state presenti a entrambe le esplosioni atomiche, sopravvivendo a esse e venendo perciò chiamate “gli otto fortunati”. Tuttavia, di almeno sei di queste persone, ogni articolo che li cita (pochi, per la verità) non specifica nulla, nemmeno il nome, e nessuno di questi articoli proviene da fonti ufficiali.
Ci sono dunque buone ragioni per credere che si tratti solo di una suggestiva leggenda
Le altre versioni si concentrano sugli unici due nomi disponibili: Enemon Kawaguchi e Tsutomu Yamaguchi. Il primo sarebbe nato nel 1909 e morto nel 1957 per una leucemia contratta in seguito all’esposizione alle radiazioni, dopo aver trascorso gli anni successivi alla guerra in un ospedale psichiatrico perché troppo sconvolto dall’esperienza; il secondo è sicuramente vissuto dal 1916 al 2010 ed è morto di cancro allo stomaco (malattia quasi certamente non correlata all’esposizione alle radiazioni, vista l’età avanzata del paziente e la notevole incidenza della patologia nella popolazione giapponese in generale), dopo essere stato a lungo un attivista pacifista ed essere stato incontrato dal regista James Cameron che voleva farne il consulente di un film sulle bombe atomiche (progetto accantonato in seguito alla morte di Yamaguchi).

Sotto, Tsutomu Yamaguchi:
Molti elementi fanno credere che la storia di Kawaguchi sia in realtà un’invenzione realizzata aggiungendo elementi romanzeschi alla storia reale di Yamaguchi. Si dice che l’uomo era un ingegnere (come Yamaguchi) e che lavorava allo stabilimento della Mistubishi di Hirosima. In realtà, a Hiroshima, non c’è mai stato uno stabilimento della Mistubishi, mentre ce n’è uno molto importante a Nagasaki (e ci lavorava Yamaguchi). Kawaguchi sarebbe sopravvissuto all’esplosione che avrebbe distrutto il suo ufficio a 5 km dallo scoppio e poi avrebbe vagabondato per la città fino alla periferia, sarebbe salito su un vagone ferroviario abbandonato, addormentandosi per lo sfinimento e si sarebbe poi risvegliato su un treno diretto a Nagasaki.
Qui, appena arrivato, avrebbe assistito alla seconda esplosione atomica. Alla sua morte, sarebbe stato registrato come caso numero 163641 tra quelli studiati dalla Commissione istituita dagli americani. Ma nei documenti redatti dalla Commissione stessa non c’è nulla di relativo a questo caso, che pure dovrebbe essere uno dei più importanti. Né viene mai nominato nelle biografie di Yamaguchi, benché a tutti gli effetti il fatto che due colleghi della stessa azienda si trovino a vivere casualmente la stessa esperienza, in un Paese di milioni di persone, rappresenta una coincidenza che non può passare sotto silenzio.
Di Yamaguchi, invece, si sa per certo che si trovava a Hiroshima per un viaggio di lavoro e che, al momento dell’esplosione, si trovava a 3 km da questa ed era appena sceso da un tram. Riportò danni ai timpani e una cecità momentanea, oltre ad alcune ustioni e alla perdita dei capelli. Raggiunse un ospedale rimasto in piedi (non si sa se sia quello di Hachiya, che non ne parla: peraltro, rispetto alla media dei pazienti, Yamaguchi era un caso lieve) e ricevette i primi soccorsi, poi riuscì a prendere un treno per Nagasaki. La mattina del 9 agosto, da vero stakanovista, nonostante le ferite, era in un ufficio, e stava spiegando ai suoi dirigenti cos’era accaduto a Hiroshima, quando a 3 km di distanza esplose la seconda bomba atomica.
Un documentario americano intitolato “Twice survived”, realizzato nel 2006, parla addirittura di 165 persone che sarebbero sopravvissute a entrambe le bombe, ma finora il riconoscimento ufficiale in tal senso è stato concesso al solo Yamaguchi.
Sotto, un video amatoriale in inglese racconta la sua storia:
I Santi di Nagasaki
Quella di Nagasaki è, per dirla con le parole dello storico americano Frank W. Chinnock (che dedicò a questa vicenda un importante libro, tradotto anche in Italiano), “la bomba dimenticata”. La sua vicenda è stata quasi completamente oscurata da quella di Hiroshima, nonostante la portata dell’evento in termini di distruzioni e conseguenze sia identica. Per molti versi, la storia di questa città è ancora tutta da scoprire.
Sotto, Takashi Nagai:

Nagasaki ospitava, tra l’altro una comunità cattolica abbastanza numerosa e sicuramente significativa. In Giappone il cristianesimo è sempre stato poco diffuso, anche perché i primi tentativi di predicazione evangelica, nel XVI secolo, furono stroncati con violente persecuzioni che portarono alla crocifissione dei missionari. Il più importante di questi predicatori, un giapponese di origine aristocratica oggi celebrato dalla Chiesa Cattolica come San Paolo Miki (1556-1597), come i suoi compagni San Giacomo Kisai e San Giovanni Soan, era originario proprio della zona di Nagasaki.
Tuttavia, quando nel XIX secolo il Giappone si aprì all’influenza culturale occidentale, il ritorno dei missionari cristiani portò a un certo numero di conversioni, spesso legate anche al carisma del leader delle piccola comunità che si formavano. In questo senso, Nagasaki fu particolarmente fortunata, perché dal 1931 al 1936 ospitò San Massimiliano Kolbe, il futuro martire di Auschwitz (1894-1941), che vi fondò un monastero francescano che ebbe molto seguito.
L’influenza di Kolbe fu molto viva soprattutto sul medico Takashi Nagai (1908-51), battezzato nel 1934 con il nome di Paolo proprio in onore di Paolo Miki. Nagai veniva da una famiglia di insigni medici ma le conseguenze di una meningite patita nell’infanzia gli impedirono, una volta conseguita brillantemente la laurea, di impegnarsi nella professione, per cui si dedicò alla ricerca, soprattutto nel campo della radiologia, divenendo docente universitario.
Dal 1937, però, fu chiamato a servire come medico militare al fronte, facendo esperienze che rafforzarono il suo pacifismo e la sua fede religiosa. Tornato in patria, si dedicò soprattutto ai più bisognosi, lavorando incessantemente, anche dopo che nel giugno 1945 gli fu diagnosticata una leucemia che gli lasciava, secondo i colleghi che lo visitarono, al massimo tre anni di vita. Il 9 agosto era in servizio all’ospedale e riportò una grave ferita alla testa, dalla quale impiegò due giorni a riprendersi, prima di poter tornare a casa e trovare tra le macerie di questa i resti dell’amatissima moglie Midori, un’insegnante pure convertita al cattolicesimo con il nome di Maria (i figli, fortunatamente, erano sfollati in campagna).
Dal 1946, Nagai fu così invalido da non poter più lavorare, ma riuscì a trovare le forze per scrivere un libro sull’esperienza della bomba, “La campane di Nagasaki”, tradotto anche in Italiano. Sentendosi vicino alla fine, la mattina del 1° maggio 1951 si fece trasportare nello stesso policlinico in cui fino a cinque anni prima aveva prestato servizio come docente, per permettere agli studenti di assistere dal vivo all’agonia di un uomo malato di cancro.
Assistito da loro e dal figlio maggiore Makoto, morì lì, la sera dello stesso giorno
Il processo canonico che porterà Takhashi Nagai alla canonizzazione procede lentamente ma inesorabilmente: finora è arrivato allo stadio di “servo di Dio”.
L’attrice ribelle smembrata
Si chiamava Midori Naka, era figlia di un generale, nata a Tokio il 18 giugno 1909, ed aveva studiato in uno dei migliori collegi della capitale. Affascinata dalla cultura occidentale, aveva intrapreso la carriera di attrice di teatro.

In Giappone, ancora oggi, è molto diffuso il teatro tradizionale, molto complesso e variegato; negli anni in cui fu attiva Midori Naka, caretterizzati da politiche di forte nazionalismo, era praticamente l’unico ammesso. La Naka, invece, preferiva dedicarsi al teatro detto “Shingeki”, con stile e repertorio occidentali, e già all’inizio della carriera ottenne molti successi, specie in “La signora delle camelie”, tratto dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas figlio (la stessa opera che ha ispirato “La traviata” di Verdi). Tuttavia, le compagnie che inscenavano queste rappresentazioni lavoravano in modo semiclandestino, perché erano sempre tenute d’occhio dalla polizia. Nella seconda parte degli anni ’30, la casta dei militari divenne pressoché onnipotente, al punto da imporre le proprie scelte anche all’imperatore, e il Giappone divenne sempre più simile alla Germania nazista.
Se il repertorio delle compagnie di teatro Shingeki appariva lontanamente sgradito a qualche nazionalista fanatico, le compagnie venivano chiuse e gli autori dei testi incarcerati. Per questo, il repertorio preferito era quello ottocentesco. La Naka lavorò a lungo, dal 1931, nella compagnia chiamata “Piccolo Teatro Tsukiji”: quando questa fu sciolta dalla polizia, nel 1940, per qualche tempo, lavorò in un locale gestito dalle sue sorelle (ne aveva tre); nel 1942 entrò in una nuova compagnia, chiamata “Dolore e piacere”; anche questa fu chiusa dalle autorità, all’inizio del 1945, quando comunque l’attività teatrale a Tokio era ormai quasi impossibile per via degli incessanti bombardamenti. Midori Naka ricevette però, nel marzo 1945, la proposta di entrare come protagonista nella compagnia “Fiore di ciliegio” che compiva tournées per tutto il Giappone, e la accettò entusiasticamente.
Poiché Hirosima sembrava destinata a essere risparmiata dai bombardamenti, la compagnia “Fiore di ciliegio” si trasferì lì, il 7 giugno 1945, per dare inizio alla stagione. Gli spettacoli allietavano le serate degli operai delle tante fabbriche di materiale bellico della zona. I fondi disponibili però non erano molti e l’intero organico, composto da undici persone, andò a vivere in una casa a circa 700 metri dal punto in cui sarebbe esplosa la bomba, dividendola con un’altra compagnia teatrale più piccola, che contava sei membri. La mattina del 6 agosto 1945, Midori Naka era già vestita e si trovava in cucina per fare colazione, quando le sembrò di sentire il botto dello scoppio di una caldaia e perse conoscenza.
Quando rinvenne, era nel buio e indossava solo le mutande
Capì di trovarsi sotto le macerie della casa e si liberò. Era apparentemente illesa, a parte qualche abrasione alla schiena, alle mani e alle gambe e dei conati di vomito che la coglievano all’improvviso, mentre tredici delle diciassette persone che si trovavano nella casa erano morte sul colpo. Intorno bruciava tutto, quindi la Naka decise di raggiungere il fiume poco distante e di gettarsi in acqua. La corrente la spinse a qualche centinaio di metri di distanza, dove fu vista e ripescata da alcuni soldati che le diedero un lenzuolo per coprirsi.
Riuscì poi a raggiungere la stazione ferroviaria e, facendosi riconoscere, trovò un posto su uno dei primi treni che, qualche giorno dopo, cominciarono a partire verso Tokio. Arrivò nella capitale il 10 agosto, ancora avvolta nel lenzuolo che le avevano dato i soldati e si recò a casa delle sorelle.
Poiché le sue condizioni continuavano a peggiorare, i suoi familiari la fecero ricoverare all’Ospedale Universitario di Tokio, il 16 agosto. Era in uno stato già critico, con febbre alta, forte anemia, pochissimi globuli bianchi e piaghe da decubito sulla schiena. Ricevette diverse trasfusioni di sangue, ma ugualmente la febbre restava altissima, le sue analisi peggiorarono e perse i capelli, mentre le ferite si ulceravano. Il 23 agosto il corpo cominciò a coprirsi di macchie emorragiche. Alle 12:30 del 24 agosto, Midori Naka morì, all’età di 36 anni. La morte fu ufficialmente ascritta a una “sepsi diffusa” ma il professor Masao Tsuzuki, primario del reparto in cui era stata ricoverata ed esperto di radiologia, mise subito la sua fine in relazione con l’esposizione alla bomba.
La sua morte destò un vivo interesse in tutto il Giappone, perché la Naka, nonostante le condizioni in cui aveva dovuto lavorare per tutta la sua carriera, era famosissima e considerata una delle donne più belle, eleganti e raffinate del Paese. Molti giapponesi vennero a conoscenza del fenomeno della “malattia da radiazioni” proprio attraverso la sua storia.
Non si sa bene perché, Midori Naka non venne subito seppellita: il suo cadavere fu infatti conservato in un frigorifero. Qualche settimana dopo la sua morte, gli americani che intanto avevano occupato il Giappone e istituito una commissione scientifica per studiare gli effetti delle radiazioni sull’uomo, vennero a conoscenza di questo e sequestrarono il corpo dell’attrice per portarlo negli Usa e sottoporlo a esami molto approfonditi.
Solo dopo decenni di richieste da parte della famiglia, Midori Naka è potuta tornare a casa, quando erano ormai gli anni ’70. Il corpo era stato smembrato e i diversi organi furono restituiti in vasetti di vetro. Le cartelle con gli studi compiuti sui suoi resti non sono state disponibili fino a pochi anni fa, quando sono state recuperate da alcuni studiosi giapponesi.
Sotto, un video amatoriale in inglese racconta la sua storia:

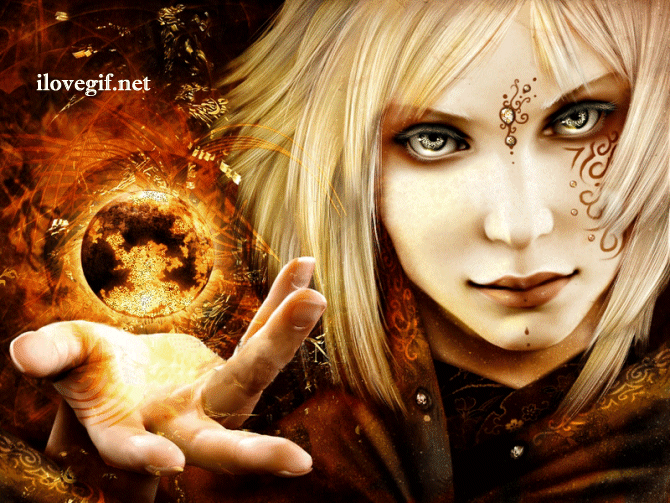

























Commenti